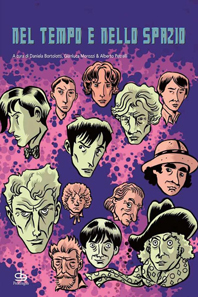Quando avevo una decina d’anni, i miei genitori decisero che nella vita è fondamentale saper nuotare, perché il nuoto non solo fa bene ed è uno sport completo, ma può salvare la vita, metti che venga un’inondazione?
(a Bologna le inondazioni un giorno sì e uno no, va detto)
Così mi iscrissero in maniera totalmente arbitraria a un corso di nuoto al Villaggio del Fanciullo, tardo pomeriggio di lunedì e giovedì, vasca piccola dove si tocca, bambini principianti, cose così. Io non concepivo l’esigenza di saper nuotare come fondamento dell’esistenza, mi sembrava più utile saper fare la ruota o non cadere di testa dalle parallele asimmetriche, ma se dovevo farlo ok, lo avrei fatto, ero una bambina abbastanza pugnetta ma poi alla fine mi si convinceva.
Quindi iniziai: un piccolo boiler in costumino intero e cuffia che si affacciava al bordo vasca della vita.
Della mia totale assenza di predisposizione a qualsiasi tipo di sport se ne aveva già avvisaglia, dalla grazia con cui rotolavo avvolta nei body di ginnastica artistica fino alla lentezza con cui correvo durante l’ora di educazione fisica a scuola, ma il colpo di grazia lo diede proprio il nuoto: se è vero quel che dice Archimede nel suo Principio, cioè che ogni corpo immerso in un fluido è sottoposto ad una spinta verticale dal basso verso l’alto uguale al peso del fluido che esso sposta, è evidente che Archimede non ha mai conosciuto la sottoscritta, che non solo non riusciva a nuotare, ma non riusciva nemmeno a galleggiare.
A volerla dire tutta ero bravissima nelle apnee, cioè stare sotto il livello dell’acqua trattenendo il fiato non mi faceva minimamente paura, e questo avrebbe già dovuto dirmi tanto, ma non è l’argomento del post.
A questo piccolo grande dramma del non stare a galla, si aggiungeva infatti il terrore dei tuffi, che gli altri bambini percepivano invece come momento di gioco finale di ogni lezione e che attendevano con impazienza, momento che invece per me significava paura e terrore perché nel tuffarmi era racchiusa l’essenza pura del Moriremo tutti annegati in una vasca da un metro al Villaggio del Fanciullo sotto gli occhi di mia mamma.
Mentre immaginavo titoli di cronaca, prime pagine del Carlino Bologna, strazio dei parenti e dello staff, escogitavo qualsiasi strategia per imboscarmi sempre in coda alla fila, facendomi passare davanti da tutti e contando i minuti nel grosso orologio sopra la vasca grande, sperando di farla franca, ma purtroppo non accadeva mai perché la sadica maestra di nuoto (che allora mi sembrava un’anziana, ripensandoci non avrà avuto più di vent’anni) lo sapeva e si ricordava di chiamarmi avanti.
Non è che non mi tuffassi, alla fine mi toccava volente o nolente. Ma lo facevo solo -e molto goffamente, ovvio- se l’insegnante mi aiutava accompagnandomi con la mano stretta, che successivamente diventò un “aggancio” con un solo dito, il che fa capire chiaramente che non fosse il pericolo il vero problema, ma la sensazione di lanciarmi da sola in qualcosa che non conoscevo e che per questo mi faceva paura. Nessuno lo ha capito, nonostante due stagioni di corsi in piscina, e giù di cazziatoni ad ogni lezione.
I miei desistettero dall’impresa, chiosando con un Evidentemente non è portata.
Oggi, a quarantuno anni suonati non so ancora nuotare, non sono ancora capace di galleggiare, in piscina diverto sempre tutti con le mie paranoie fuori luogo (anche perché essere quasi un metro e ottanta mi fa toccare con i piedi molto spesso!).
Però se mi date una tavoletta, un salvagente, un “aggancio” minimo, non ho paura e nuoto.
Male, ma mi muovo.
I tuffi però no, quelli non li ho mai più fatti.
LdC